"Debito ecologico. Chi deve a chi?"
17.12.03
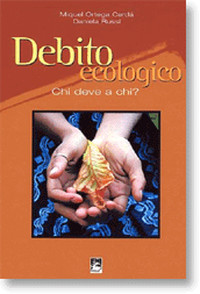
Che la maggior parte dei Paesi poveri abbia contratto, nel corso degli ultimi decenni, un grosso debito estero nei confronti delle nazioni più ricche è un fatto noto. Come è risaputo che il tentativo di ripagare interessi sempre più esosi abbia pesantemente condizionato - e continui a farlo - le politiche economiche e sociali dei Paesi del Sud del mondo, relegandoli spesso in una spirale di crescente miseria e dipendenza dall'estero e dagli organismi finanziari internazionali. Meno nota, invece, è l'esistenza parallela di un altro tipo di debito, contratto questa volta dalle nazioni più sviluppate ai danni dei popoli più poveri del Pianeta.
Si tratta di un debito più difficile da quantificare economicamente poiché chiama in causa non prestiti e transazioni in denaro ma l'uso - e l'abuso - delle risorse naturali, l'utilizzo gratuito di acqua, aria, suolo, l'"appropriazione indebita" di conoscenze ancestrali su sementi agricole o piante medicinali. E' ciò che il fisico Miguel Ortega Cerdá e l'economista Daniela Russi definiscono «il debito ecologico del Nord verso il Sud», nel loro libro "Debito ecologico. Chi deve a chi?" (Emi, pagine 94, euro 7), in cui ne propongono tra l'altro una sorta di "monetizzazione", per aumentarne la coscienza e la rilevanza a livello di relazioni internazionali. «Il debito ecologico è il debito contratto dai Paesi industrializzati verso gli altri Paesi a causa dello sfruttamento passato e presente delle risorse naturali, dei danni ambientali esportati e del libero utilizzo dello spazio ambientale globale in cui vengono depositati i rifiuti», scrivono gli autori, illustrando un concetto già elaborato a partire dagli anni Novanta nell'ambito di una serie di iniziative locali e internazionali sul tema ambientale: dal vertice alternativo di Rio de Janeiro del 1992 alle campagne dell'anno giubilare che mettevano in relazione l'abolizione del debito estero dei Paesi poveri all'esistenza appunto di un "debito ecologico" assai più rilev ante. Nel libro Ortega Cerdá e Russi passano in rassegna le componenti di questa voce e le analizzano entrando nel merito tecnico e scientifico delle questioni pur senza rinunciare a uno stile sintetico e a un taglio divulgativo e anche didattico, come dimostra la struttura del testo suddiviso in brevi capitoli corredati da schede per l'approfondimento e da un notevole repertorio di siti Internet. Veniamo così a conoscenza della teoria del «debito di carbonio, prodotto dall'uso massiccio che i Paesi industrializzati fanno del servizio ambientale di assorbimento di CO2 da parte dell'atmosfera, della nuova vegetazione, del suolo e degli oceani». Nel corso degli anni Novanta, «le emissioni di gas a effetto serra nei Paesi industrializzati furono otto volte più elevate (in termini pro capite) di quelle dei Paesi in via di sviluppo», rilevano gli autori, secondo i quali il Protocollo di Kyoto patrocinato dall'Onu nel '97, pur rappresentando «un piccolo passo in avanti in materia ambientale», così com'è «non affronta aspetti come l'equità e la giustizia, e stabilisce "diritti di proprietà" sulle riduzioni di emissioni che possono essere commercializzate tra i diversi Paesi». Una forma di debito "privata" è invece rappresentata dal «passivo ambientale»: l'insieme dei danni, in termini di inquinamento e degrado di risorse ed ecosistemi, prodotti da un'impresa, anche a seguito di incidenti.
Un passivo che spesso è prodotto da aziende trasnazionali del Nord del mondo nelle regioni del Sud, dove «la legislazione ambientale è meno severa e la forza politica delle popolazioni locali e dei governi è minore». Ancora senza un esito soddisfacente i tentativi di mettere a punto una regolamentazione internazionale, così come per il trasporto di rifiuti pericolosi che, «se lasciati al libero arbitrio del mercato, seguono inevitabilmente la strada che oppone minor resistenza, dai Paesi industrializzati verso i Paesi più poveri». È peculiare, nonché molto rilevante, un'ultima forma di debito ecologico analizzata nel libro: quella definita biopirateria, e cioè l'appropriazione da parte di enti e imprese delle nazioni industrializzate di tradizionali saperi locali su sementi e piante e della stessa biodiversità, fino alla pretesa di riscuoterne i diritti come se si trattasse di «nuove invenzioni». Riconoscere l'esistenza del debito ecologico è - per gli autori - un passo urgente e irrinunciabile. Ma è necessario andare oltre, applicando politiche e regole che mirino a risarcirlo e, in prospettiva futura, ne impediscano l'aumento. Per un dovere etico, e anche per mancanza di alternative reali. Perché - spiegava con semplicità una donna U'wa - «se uccidi la terra nessuno potrà vivere».
Sociale.network