Acqua in bottiglia: liscia, gassata e quasi gratis
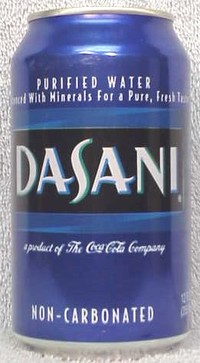
Periodo sfortunato per la Coca Cola. A dicembre è stata condannata da un tribunale indiano per lo sfruttamento dei pozzi di alcuni villaggi, a gennaio ha dovuto rispondere della spiacevole abitudine di fare fuori - in tutti i sensi - le attività sindacali negli stabilimenti colombiani. Poi sono arrivati gli inglesi. La Coca Cola ha investito 10 milioni di euro per lanciare la propria minerale fra i britannici. L'acqua Dasani stava per diventare il gadget preferito dei giovani modaioli fissati con la forma, quando è venuto fuori che la costosa bottiglietta - 1 euro e 40 per mezzo litro - contiene acqua del Tamigi depurata, e nemmeno poi tanto visto che sono stati rintracciati elevati livelli di bromato, una sostanza cancerogena. Coca Cola si è dovuta ritirare, con mezzo milione di bottigliette di Dasani fra le gambe, dal business più redditizio del momento che consiste nel trasformare un prodotto economico e ampiamente disponibile in uno status symbol praticamente indispensabile.
Vendere neve agli eschimesi
La pseudo-inchiesta pubblicata da Panorama questa settimana è un buon esempio di pubblicità strisciante. Sprizzando entusiasmo per il primato mondiale di consumo, i giornalisti vengono risucchiati dai soliti luoghi comuni pubblicitari: la minerale è trendy, è salutare ed è talmente buona da rendere necessario l'aiuto di appositi sommelier, che i grandi ristoranti si affrettano a istruire. A margine campeggiano schemi "esplicativi" che guarda caso, classificano quella del rubinetto fra le "acque trattate" e le minerali, di sorgente o meno, fra quelle "non trattate", ignorando evidentemente che molti acquedotti attingono, appunto, direttamente alla fonte. Ma com'è possibile che in un paese noto fin dall'antichità per le sue fonti il 98,2 degli abitanti compri l'acqua imbottigliata almeno una volta l'anno? «E' nata prima la domanda o l'offerta?» si chiedono gli autori, mentre si accingono a dare il loro contributo a rafforzare una domanda fittizia.
In realtà il boom della minerale è stato costruito lentamente, a scapito di un sistema pubblico di gestione e di controllo delle acque di tutto rispetto. Essendo notoriamente difficile vendere neve agli esquimesi, è stata impiegata una strategia complessa e a lungo termine. Prima di tutto sono stati lasciati andare in rovina gli acquedotti, tagliando sui fondi destinati alla manutenzione pubblica, poi si è passati all'assalto del fronte mediatico, essenziale per riuscire a convincere gli esquimesi a pagare la neve. E la pubblicità, infatti, risucchia quasi tutte le risorse delle aziende.
Ci sono voluti vent'anni ma il risultato è eccezionale: più della metà della popolazione italiana non beve l'acqua del rubinetto ed è disposta a riempirsi la casa di bottiglie, che vanno poi a riempire le discariche, pagando la minerale dalle 300 alle 600 volte più di quella dell'acquedotto. Strano perché, in genere, i concittadini sono sensibili al portafoglio. Ma gli spot sono stati così efficaci che ormai niente sembra distoglierli dalla convinzione che l'acqua del rubinetto sia veleno. Non credono agli amministratori né all'Organizzazione mondiale della sanità che, in un rapporto del '99, non si capacitava del fatto che «benché l'acqua sia disponibile e di buona qualità (...) solo il 47 per cento delle famiglie italiane intervistate dichiara di bere l'acqua del rubinetto».
La truffa
Oggi la quasi totalità delle marche italiane, che avevano sfondato sul mercato internazionale proprio grazie alla fama dell'acqua italica, sono state assorbite da transnazionali come la Nestlé, che ha risucchiato San Pellegrino, Levissima e Panna, o come la Danone, che si è bevuta Ferrarelle e San Benedetto. In realtà le corporation sono state attirate soprattutto dalla vantaggiosa situazione normativa che vige nel nostro paese. Come dargli torto? In primo luogo la materia prima è quasi gratis perché nella maggior parte delle regioni, soprattutto in quelle del nord-est da dove proviene circa la metà dell'acqua imbottigliata, le aziende si servono delle stesse sorgenti dei privati cittadini, ma a condizioni economiche molto più favorevoli. Qualche anno fa Paolo Cacciari, consigliere regionale di Rifondazione, scoprì che le aziende pagavano l'acqua circa 0,07 lire a litro, mentre ai cittadini costava una lira al litro. Quando Cacciari propose di equiparare le tariffe venne accolto da un silenzio tombale e a quanto risulta nessuno, né prima né dopo, ha osato mettere in dubbio il regime quasi gratuito.
L'altra questione riguarda l'aspetto sanitario. Perché l'acqua del rubinetto venga dichiarata potabile dai funzionari del ministero della Sanità, deve rispettare una trentina di parametri sanitari, requisito che viene verificato due volte al giorno. Per l'acqua in bottiglia, invece, i parametri richiesti sono molti di meno - circa la metà - e i controlli vengono effettuati random - circa una volta al mese - o dietro sollecitazione del magistrato. L'acqua "pubblica" deve insomma dimostrare di essere potabile ogni mattina, mentre quella "privata" è potabile fino a prova contraria. In teoria quando il ministero della Salute richiede una verifica della qualità della minerale i controlli vanno effettuati subito, ma le analisi sono condotte dagli esperti delle aziende e non da ispettori pubblici come nel caso degli acquedotti. In pratica, però, le istituzioni si muovono con estrema lentezza. Quando, nell'autunno del 2002, il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello scoprì delle irregolarità nella sorgente piemontese di Pian della Mussa e in alcune bottiglie di Fiuggi, sollecitò subito il ministero. Ma l'ingiunzione ministeriale che richiedeva nuove analisi a 500 aziende produttrici - cioè praticamente tutte - partì solo nel marzo dell'anno dopo. Nel frattempo quanta acqua ci siamo bevuti?
Sociale.network