"I cambiamenti climatici"
Il riscaldamente globale non esiste. Oppure, se c'è, è un fenomeno naturale. Quanto a capire se l'emissione dei gas sia dannosa, la strada è ancora lunga. Meglio aspettare e preparsi a curare le conseguenze dell'effetto serra che applicare il trattato di Kyoto. Così, tra mille scuse, l'ambiente resta fuori dalle agende dei politici e degli stati. America in testa. Edito da Carocci, un testo di Dinyar Godrej svela molti dei retroscena che si nascondono dietro alle politiche neoliberiste del cambiamento climatico. Dalla crescita illimitata all'illusione dell'inesauribilità delle risorse
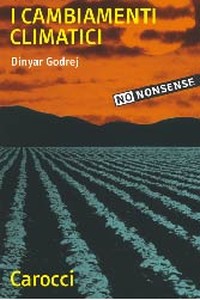
Era il maggio 1982. Margaret Thatcher, al culmine dei bombardamenti che mandavano in pezzi navi, aerei e con essi le vite di centinaia di argentini e inglesi, salutava euforica la guerra delle Malvinas/Falklands: «è emozionante - disse - avere tra le mani una vera crisi quando hai trascorso metà della tua vita politica affrontando questioni banali come l'ambiente». Eppure, nemesi delle questioni banali, nei vent'anni a seguire l'ambiente avrebbe colonizzato le prime pagine dei giornali (e la testa della gente) più intensamente e caparbiamente che non le pur spettacolari, deliranti guerre scatenate dagli anglo-americani. Lo fiutava la stessa lady di ferro quando, sette anni dopo, all'intiepidirsi della questione del riscaldamento globale, profetizzava: «nessuna questione sarà più controversa della necessità di controllare le emissioni di biossido di carbonio [...] Non si può semplicemente rimanere senza far nulla [...] Ogni paese deve contribuire». Il suo paese avrebbe contribuito, pochi giorni dopo, boicottando la proposta (olandese) di ridurre le emissioni di biossido di carbonio (uno dei grandi responsabili, assieme al metano, del contributo umano all'aumento dell'effetto serra). Oggi come allora l'ambiente è tanto al centro delle preoccupazioni planetarie quanto pericolosamente fuori, nella pratica concreta, dall'agenda dei politici. Oggi come allora le giustificazioni all'inerzia di fronte all'allarme sul global warming ci vengono fornite in quattro, quasi comiche, versioni. Prima versione, della negazione: il riscaldamento globale non esiste, è un'illusione oppure una passeggera fluttuazione naturale. Lo dice per esempio, Fred Singer, professore emerito di scienze ambientali all'Università della Virginia: anche se gli ultimi cento anni sono stati «leggermente più caldi della media» (a causa della fine di un periodo di «piccola glaciazione» esauritosi attorno al 1850), non ci sono prove di un aumento della temperatura negli ultimi cinquant'anni. Lo dicono anche alcuni personaggi in Italia. La loro tesi non è più di moda, specie da quando il disastro ha cominciato ad affacciarsi sui paesi ricchi. E da quando dozzine di studi mostrano, con livelli di confidenza elevatissimi, che l'ultimo decennio è stato il più caldo del millennio e che almeno quattrocento specie di esseri viventi hanno cambiato radicalmente abitudini a causa del calore: animali e piante (380 specie, ad esempio, solo in Gran Bretagna) si stanno spostando più a nord o più in montagna, stanno anticipando la fioritura o la deposizione delle uova, stanno invadendo habitat un tempo a loro estranei, o, più semplicemente, stanno morendo, come i coralli.
C'è poi una seconda versione, dell'innocenza: il riscaldamento c'è, ma è un fenomeno naturale (dovuto a una fluttuazione dell'attività solare, a piccole mutazioni dell'inclinazione terrestre, a fattori sconosciuti) nel quale probabilmente l'uomo ha un ruolo marginale. Anch'essa ha perso molti sostenitori, perché poco compatibile con i dati a disposizione. La terza versione, (potremmo chiamarla «nel dubbio, temporeggia»), recita invece: il riscaldamento c'è, ma i modelli climatici che abbiamo a disposizione sono talmente rudimentali che è impossibile prevederne entità e conseguenze, ed è difficile capire quanto sia utile ridurre l'emissione dei gas. Conseguenza: è inutile ratificare e applicare il trattato di Kyoto, che invece ha costi certi e altissimi. Lo dicono, per esempio, gli scienziati dello European Science and Environment Forum, entità (il cui sito è tanto chiaro sugli obiettivi quanto reticente riguardo ai nomi dei finanziatori privati) creata nel 1996 per attaccare le conclusioni raggiunte dai duemilacinquecento scienziati di tutto il mondo riuniti dalle Nazioni Unite nell'Ipcc (il comitato intergovernamentale sul cambiamento climatico). Secondo loro, e i loro colleghi americani del George Marshall Center di Washington, non bisogna dare ascolto ai sostenitori del «mito del riscaldamento globale»: anche se i gas serra «possono contribuire all'aumento di temperatura», non si sa ancora se siano un elemento dominante del cambiamento. Inoltre - dicono - non sappiamo di quanto si stia scaldando il pianeta, né se il riscaldamento possa trovare una forma di auto-controllo in seguito a retroazioni di origine naturale. Le azioni richieste dal protocollo di Kyoto sono - aggiungono - «ingiustificate» e dettate «da una visione apocalittica di cosa accadrebbe nel 2100».
C'è infine una quarta versione (sublime), di rassegnata pazienza: il global warming c'è, è effettivamente legato ai gas serra che da centocinquant'anni immettiamo nell'atmosfera a un ritmo crescente. Per frenare il riscaldamento occorrerebbe ridurre tali emissioni. Ma ormai, purtroppo, l'entità del danno è tale che i tagli minimi richiesti dal protocollo di Kyoto ai paesi industrializzati (in media il 5,2% in meno rispetto a quanto emesso nel 1990, anziché il 50-70% in meno considerato necessario dall'Ipcc) avrebbero risultati irrisori sulla temperatura. E costerebbero molto. Tanto vale non imporre tagli e usare i soldi per prepararsi a curare le conseguenze dell'effetto serra. Il governo statunitense ha usato le quattro versioni per dilazionare, aggirare, deridere ogni politica di controllo sulle emissioni di gas serra. Oggi è campione di variazioni sul tema della quarta, che condisce con lo slogan, così sincero, così americano, con il quale già Bush senior, ventun'anni fa, rifiutò di firmare parte degli accordi della Conferenza di Rio sull'ambiente: «il nostro tenore di vita non è negoziabile».
Di fronte a tanta serena lungimiranza, vien da pensare: che bello, ogni tanto, un po' d'insano allarmismo. È uno dei motivi per cui ci piace sfogliare, in quest'agosto un po' ansiogeno e surreale, fra incendi e black-out, I cambiamenti climatici (Carocci editore, pp. 160, 10,50 Euro), agile testo divulgativo di Dinyar Godrej. Free-lance anglo-indiano, collaboratore del New Internationalist, Godrey, oltre a spiegarci l'abc dell'effetto serra, ha raccolto una impressionante antologia di studi e dati che confermano l'imponenza del cambiamento climatico in atto: con piglio classificatorio, ci mostra, sparsi nei cinque continenti, le siccità e le inondazioni da record, le primavere anticipate, gli inverni troppo bagnati, i profughi ambientali, le barriere coralline sbiancate, gli incendi da milioni di ettari. Cita (piacevole e non banale variazione dell'idea del politically correct) studi scientifici fatti nel sud del mondo da scienziati del sud del mondo. Elenca le conseguenze, quelle probabili e quelle già in atto (entrambe terrificanti), del riscaldamento globale sulla salute umana, l'agricoltura, l'economia, gli ecosistemi. Poi, nel raccontarci la storia delle politiche del cambiamento climatico, ce ne mostra i retroscena come uno dei tanti capitoli del grande libro della macchina del neoliberismo economico, del suo imperativo alla crescita crescente, del miraggio dell'illimitatezza delle risorse (ottimamente commentati da Enzo Scandurra sul manifesto del 15 agosto). Vediamone due esempi. Nel 1979 la prima conferenza mondiale sul clima, a Ginevra, si chiudeva con un appello ai governi del pianeta per «prevenire e affrontare le conseguenze del cambiamento climatico indotto dall'uomo». Dieci anni dopo le Nazioni Unite, su pressione di diversi rapporti scientifici preoccupanti, decisero di istituire l'Ipcc, il Comitato intergovernamentale sul cambiamento climatico. Nel maggio 1990 il primo documento dell'organismo internazionale dichiarava difficile misurare l'impatto dell'uomo sul clima, ma concludeva che l'immissione dei gas serra non poteva non averne uno: se si continuava ad emettere i gas allo stesso ritmo, la temperatura globale poteva salire di diversi gradi in meno di un secolo. Per stabilizzare il clima, diceva l'Ipcc, occorre tagliare le emissioni di biossido di carbonio del 50-70%. Significava dire addio, e subito, alle energie fossili. Per le industrie del petrolio e del carbone, che fatturano tremila miliardi di dollari l'anno, era il momento di agire.
Prima ancora che il rapporto dell'Ipcc fosse completato e distribuito ai giornalisti, Brian Flannery, climatologo stipendiato dalla Exxon, dichiarava alla stampa che i modelli climatici usati dall'Ipcc per le previsioni a lungo termine erano «scientificamente inaffidabili». Poco dopo, nasceva la Global Climate Coalition, ente (oggi dismesso) finanziato da tutte le principali industrie che producono e consumano petrolio o carbone. Aveva per obiettivo quello di screditare le conclusioni degli scienziati dell'Ipcc e amplificare la voce della minoranza scettica. Cominciava così una guerra che Godrej racconta con puntiglio divertito e ricchezza di personaggi. Il deputato repubblicano Dana Rohrabacher è fra i più folclorici. Famoso per riuscire a confondere gli idrocarburi (il petrolio) coi carboidrati (la pastasciutta), dichiarò che investire in ricerche sul riscaldamento globale era come «buttar soldi in un pozzo senza fondo», e che era stanco di ascoltare «allarmismi inutili», come quello sul buco dell'ozono, che - a sua detta - «si era rivelato l'ennesimo falso allarme dell'ultimo ambientalista ingenuo, un grido che abbiamo già sentito quando gli allarmisti hanno costretto gli americani a togliere i pannelli di amianto dalle scuole».
Alla fine del 1995 era pronto un secondo rapporto dell'Ipcc. Ma sarebbe stato pubblicato solo dopo sei mesi di correzioni, discussioni, limature, tagli radicali. La conclusione del rapporto, racconta Godrej, nella versione originale recitava, cautamente, così: «i cambiamenti climatici suggeriscono un'influenza dell'uomo sul clima». Fu giudicata troppo estrema. Dan Pearlman, procuratore di Washington, rappresentante dei produttori di carbone e petrolio e coordinatore della delegazione di Arabia Saudita e Kuwait, istigò una ridda di obiezioni. L'espressione «i cambiamenti climatici» non andava bene: troppo allarmista. Fu cambiata in «l'insieme delle prove». Parlare senza mezzi termini di «un'influenza dell'uomo sul clima» era terrificante. Fu aggiustato in «un'influenza discernibile». E così via. Ma le limature non sarebbero bastate a difendere gli scienziati dell'Ipcc da attacchi al vetriolo. Benjamin Santer, scienziato americano cui era stato affidato il compito di correggere il testo, fu accusato sui media di corruzione e incompetenza. Rohrabacher scrisse al Ministro dell'Energia statunitense chiedendo di revocare i finanziamenti al laboratorio del ricercatore.
Godrej documenta bene anche il fallimento della Conferenza di Kyoto del 1997. I paesi dell'Opec sostennero che non c'erano prove scientifiche sufficienti a decidere limitazioni serie all'emissione di biossido di carbonio. Gli Usa e il Canada (i due paesi con emissione pro capite di gran lunga più alta del mondo) dissero che imporre tagli solo ai paesi ricchi avrebbe dato un «ingiusto vantaggio» ai paesi emergenti, con perdita di posti di lavoro in Nord America. Il capo della delegazione cinese (la Cina è seconda al mondo per emissioni totali), forte del fatto che ci sono più automobili a Los Angeles che in tutta la Cina, rispose: «nei paesi sviluppati avete un'automobile ogni due persone, e volete negarci di usare l'autobus?». L'accordo finale fu che, a fronte di un impegno collettivo dei paesi sviluppati a raggiungere entro il 2010 un taglio medio del 5,2% sulle emissioni del 1990, l'Australia aveva il diritto di aumentare le proprie dell'8%, l'Islanda del 10%, Canada e Giappone promettevano un taglio del 6%, gli Usa del 7%, l'Unione Europea dell'8%. Il tutto fu presto smentito nei fatti: le emissioni, anziché diminuire, aumentarono. Poco dopo, più limpidamente, gli Usa abbandonarono ogni impegno su Kyoto, per non «mettere a repentaglio lo stile di vita americano».
Così fu. Per non mettere a repentaglio tanto sudato benessere, si stabilì di sudare (e morire) di troppo benessere. Oggi il livello di biossido di carbonio in atmosfera è il più alto degli ultimi duecentocinquantamila anni (oltre trecentosessanta parti per milione, contro duecentottanta all'inizio della rivoluzione industriale). Ogni anno, grazie alla deforestazione, all'agricoltura, alla generazione di energia, all'industria, alle automobili, aggiungiamo 18 miliardi di tonnellate, da sommare a quelle che produciamo di altri gas serra importanti come il metano e i clorofluorocarburi.
Intanto, black-out e inondazioni, incendi (e i morti per il caldo: coincidenze sfortunate?) inducono a pensare che il modello di sviluppo che stiamo seguendo è insostenibile. Non solo nell'accezione ecologica di lasciare un luogo abitabile alle generazioni future, ma anche in quella banale della sopravvivenza immediata. Le Nazioni Unite hanno raccomandato l'evacuazione dell'atollo di Tarawa, nello stato del Kiribati, nel Pacifico. La Nuova Zelanda ha già promesso ospitalità al popolo dell'atollo di Tuvalu, se questo dovesse essere sommerso nei prossimi anni. L'anno a cavallo fra il 1997-98 è stato definito quello in cui «la Terra prese fuoco»: fu sconvolto dai più colossali incendi (in Asia, Russia, Amazzonia, Europa) che la storia umana ricordi.
È emozionante - potremmo dire a voler essere cinici quanto la Lady di ferro - avere tra le mani una crisi ambientale di questa portata, quando i governi passano un terzo della propria vita a negare l'esistenza dei problemi, un terzo a giurare che il problema c'è e non è colpa loro, un terzo a far guerre fuori casa per annacquare le crisi in casa. Godrej chiude il libro con un testo di Patti Smith: wrestle the Earth from the fools. Strappiamo la Terra agli scemi del villaggio.
Sociale.network