Amartya Sen: «L'identità? Non è un destino, la possiamo scegliere»
Basta leggere il titolo dell’ultimo libro di Amartya Sen e già l’identità - questa miracolosa stampella simbolica che permette di riconoscere se stessi e gli altri nel tempo - comincia a vacillare. Identità e violenza (edizioni Laterza, pp. 222, euro 15) è un pamphlet filosofico contro il pregiudizio che vorrebbe l’individuo condannato a riprodurre la cultura della comunità nella quale viene al mondo. L’identità - cristiano, musulmano, induista, ebreo, occidentale - sarebbe qualcosa che noi “siamo”, qualcosa che è in noi fin dalla nascita. Un destino che incombe e ci condanna a essere tali e quali ai nostri padri e alle nostre madri e a tutte le generazioni che ci hanno preceduto. In questo modo di ragionare si nasconde una forma di “determinismo” secondo cui l’individuo non potrebbe essere nulla di meno, nulla di più rispetto alla famiglia, la classe, il genere sessuale, la lingua e la comunità da cui proviene - come se la sua libertà di scegliere e cambiare idea, qui, non avesse il minimo margine.
Eppure, da che mondo è mondo, non sono mai esistiti uomini e donne che potessero essere ricondotti a un’unica appartenenza culturale, politica o religiosa. Amartya Sen lo ripete come un leit motiv, «la stessa persona può essere, senza la minima contraddizione, di cittadinanza americana, di origine caraibica, con ascendenze africane, cristiana, progressista, donna, vegetariana, maratoneta, storica, insegnante, romanziera, femminista, eterosessuale, sostenitrice dei diritti dei gay e delle lesbiche, amante del tatro, militante ambientalista, appassionata di tennis». Tutte queste identità insieme.
Ma il peggio è che a riprendere il rozzo riduzionismo degli individui a un’unica categoria siano addirittura gli intellettuali più accreditati del nostro tempo, in prima fila quel Samuel Huntington, artefice della formula dello “scontro di civiltà”. E il cerchio tra identità conflitti e violenza si chiude.
Oggi viviamo in un mondo globalizzato che tende alla “liquidità”, come dice il sociologo Zygmunt Bauman. I vecchi fattori di identificazione - nazionalismo, religione, lavoro - non funzionano più. Prevale un relativismo culturale. Eppure, come scrive Robert Putnam le persone hanno bisogno di “capitale sociale” e di legami d’identità per vivere meglio. Lei non rischia di sottovalutare questo bisogno?
Io non critico l’identità come tale, anzi penso che possa essere un fattore positivo di realizzazione personale, di orgoglio. L’identità di classe spinge a lottare per ridurre le disuguaglianze. L’identità degli afroamericani è stata importante nel motivare le lotte per l’integrazione e la diffusione dei diritti. Ma in tutti questi casi bisogna che si sappia che non esiste un’unica identità, che ogni individuo ha più identità e che la riduzione a un’unica identità è una semplificazione che non corrisponde alla realtà. Karl Marx nella Critica al programma di Gotha scrive che il partito tedesco ha ridotto l’identità all’identità di classe e, così facendo, ha dimenticato altre dimensioni importanti dell’individuo. Per quel che riguarda Putnam, un mio caro amico, con il concetto di “capitale sociale”, in realtà, si riferisce ad aggregazioni di identità plurali.
Le identità favoriscono i rapporti tra gli individui?
E’ una medaglia a due facce. In Germania, in alcune regioni dove c’è un senso di identità molto forte, ci sono fenomeni di intolleranza violenta contro gli immigrati. L’identità si può vedere in due modi. C’è l’identità di genere che produce positivamente un movimento delle donne e la rivendicazione di diritti. C’è un’identità di classe che produce positivamente un movimento operaio che lotta per un miglioramento. C’è un’identità nazionalista anch’essa positiva se combatte il colonialismo e l’imperialismo. Però c’è un’identità nazionalista che a volte diventa fattore negativo di discriminazione e conflitto. Anche l’identità di classe a volte può portare a ignorare altre dimensioni della vita dell’individuo che sono importanti oltre quelle di classe. La stessa identità di genere può portare a ignorare una condizione umana condivisa tra donne e uomini. Non ho nulla contro le identità, ma vanno conosciute nella loro complessità per farne un uso positivo.
Ma questo discorso funziona se l’identità si può scegliere. Le persone sono libere di scegliere le proprie radici? Forse questo può accadere nella politica dove le idee si discutono, si rielaborano, cambiano. Ma nella sfera della cultura? Nessuno sceglie la comunità all’interno della quale nasce. L’identità, in questo caso, non è un patrimonio “naturale” che ereditiamo?
E’ una buona domanda, interessante. Nell’ambito della cultura la libertà di scelta è più difficile da percepire che nella sfera della politica, eppure esiste ed è importante capirlo. La cultura, per me, non è un obbligo, non è un destino, non ci investe in maniera ineluttabile. Un esempio fra tutti, il cibo. Le abitudini di un popolo, qui, sono il risultato di tradizioni che cambiano continuamente. In India il chili arriva dai portoghesi che, a loro volta, lo importano dal Nuovo mondo. Anche in Italia sono gli arabi che portano la pasta in Sicilia e iniziano a seccarla. Il pomodoro viene dal continente americano e il formaggio dal Medioriente. Eppure consideriamo gli spaghetti un cibo tipico italiano e lo è. In occidente siamo orgogliosi di essere cristiani ma è una religione che abbiamo ereditato dal Medioriente. In Germania i popoli del nord, gli ostrogoti, i visigoti si sono trasformati, integrati, persi, ritrovati, integrati nel corso della storia. La cultura si muove, si trasforma. Se pensiamo che la cultura si sceglie, allora possiamo argomentare, ragionare, discutere, portare motivi. Si può avere un background cristiano e scegliere d’essere atei, ad esempio. Ma se pensiamo che la cultura sia un destino allora non possiamo esercitare la facoltà razionale. Nel mio libro insisto molto su questo punto della libertà umana. E la violenza insensata nasce spesso quando siamo obbligati a pensare d’essere tutti legati a un destino ineluttabile. Il sottotitolo del mio libro (nell’edizione inglese, ndr) è, non a caso, Illusion of destiny. Marx diceva che la religione è l’oppio dei popoli per dire che la religione, come una droga, ci porta a comportamenti che non ci fanno ragionare, non ammettono argomentazioni, scelte, discernimento, selezione di argomenti. Ci porta verso una strada obbligata che ci sembra destinata. La violenza, i conflitti, il terrorismo si possono combattere se si capisce che nella realtà ci sono tante possibilità di scelta.
Lo scontro di civiltà è una teoria rozza, semplicistica e deleteria quanto agli effetti politici. Sembra però che lei metta in guardia anche gli avversari di questa tesi, per esempio il movimento no global, a fare uso di contenitori altrettanto astratti e semplificati come “occidente” e “antioccidente”. E’ così?
Distinguerei due aspetti nel movimento antiglobalizzazione. Da un lato, la critica alla disuguaglianza tra una parte dell’umanità che vive in condizioni migliori e un’altra parte più sfortunata, economicamente discriminata. D’altro lato, alcuni settori del movimento interpretano questa divisione come una contrapposizione tra occidente e resto del mondo. Eppure, non possiamo far rientrare tutti i paesi in queste due categorie uniche. Ci sono molte eccezioni. Inoltre, molti attivisti del movimento vengono proprio dal mondo occidentale e il movimento no global di per sé è un movimento globale, forse il più globalizzato e intellettuale che ci sia oggi nel mondo. Nella pratica politica non si può confondere la rivendicazione universale di equità con la tentazione di ridurre a categorie astratte la complessità delle situazioni storiche, geografiche e culturali determinate che sono in continua trasformazione. E’ importante valorizzare il tema del divario economico e sociale fra gli individui, senza però ricondurre la disuguaglianza al conflitto tra identità rigide, solitarie, del tipo “occidente contro antioccidente”, altrimenti si rischia di alimentare una lettura “religiosa” delle contrapposizioni. I no global possono rispondere ai sostenitori dello scontro fra civiltà di essere invece per il dialogo tra civiltà. Ma il punto è che non esistono le civiltà come blocchi omogenei. Un “occidentale” può essere di destra o di sinistra, laico o religioso e così via. Le divisioni esistono in ogni parte del mondo e non si possono ridurre le persone a una sola dimensione. Un mondo migliore si costruisce solo se si parte dalla complessità dell’identità degli uomini. Un mondo di relazioni multiple e non in conflitto, come è probabile che avvenga, invece, se ci schiacciamo su un’unica identità.
Articoli correlati
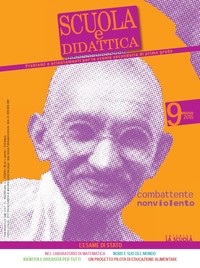 La Rivista scientifica Scuola e Didattica, La Scuola Editrice - Brescia, n. 9 Maggio 2015, presenta:
La Rivista scientifica Scuola e Didattica, La Scuola Editrice - Brescia, n. 9 Maggio 2015, presenta:Scuola e Didattica - Una Scuola per l'identità e la diversità di tutti
16 maggio 2015 - Laura Tussi Un amore oltre ogni confine...
Un amore oltre ogni confine...Silvia Marceglia, Portami con te. Dove l'amore non ha colore né religione, Gabrielli, Verona 2012
Un avvincente racconto narrato in prima persona dalla protagonista: la giovane Greta, una studentessa che frequenta l'ultimo anno di liceo nell'amata Verona. Un incontro, un ragazzo, un amore, una relazione, dove il sentimento non ha colore né religione.4 dicembre 2012 - Laura Tussi- PALESTINA
Palestinian Window: uno squarcio sulla Palestina
Un film prodotto da AIC e OPGAI racconta l'identità palestinese tra memorie, realtà e lotta18 giugno 2010 - M.C.R.
Sociale.network