L’Elogio della follia: come mettere a nudo il potere religioso
LX - I professori di teologia
Forse sarebbe meglio passare sotto silenzio i teologi [...] poiché sono persone molto arcigne e irritabili, per evitare che mi aggrediscano in massa con una serie di illazioni e mi costringano a ritrattare tutto quanto ho detto. Se poi aprissi bocca per rifiutarmi, subito mi accuserebbero d’eresia. Perché questo è il fulmine con cui immediatamente atterriscono i disgraziati a cui non concedono la loro benevolenza. Ma per quanto non vi siano uomini meno disposti di loro a riconoscere i miei benefici, in realtà anch’essi mi devono non piccola gratitudine. Beati della loro vanità, quasi che abitassero al terzo cielo, guardano dall’alto in basso e quasi con commiserazione il resto dei mortali, come se fossero bestie striscianti sulla terra. Circondati da una schiera di definizioni, deduzioni, corollari, enunciazioni implicite ed esplicite, trovano sempre tante scappatoie, che sfuggirebbero persino alla rete di Vulcano con le loro distinzioni, con le quali tagliano qualsiasi nodo, meglio che non con una scure bipenne, tanto abbondano di parole mai prima udite e di espressioni meravigliose.
Inoltre, spiegano a loro arbitrio i piú profondi misteri: in quale modo sia stato creato e disposto il mondo, per quali canali si tramandi il peccato originario, in quali modi, in quale misura e in quanto tempo si sia formato Cristo nel seno della Vergine e come nell’Eucaristia sussistano le qualità accidentali senza la corrispondente sostanza. Ma tutti questi argomenti sono abusati e ormai sorpassati. Per le menti dei teologi grandi ed illuminati non sono degni che problemi veramente importanti, come i seguenti, la cui trattazione li fa quasi rivivere: c’è un istante discernibile nella generazione divina? – Ci sono in Cristo generazioni molteplici? È possibile la proposizione: Dio Padre odia il Figlio suo? – Dio avrebbe potuto incarnarsi in una donna, o nel diavolo, o in un asino, o in una zucca, o in un ciottolo? – E allora, la zucca in questione, come avrebbe potuto predicare, fare miracoli ed essere crocefissa? Che cosa avrebbe consacrato San Pietro se avesse celebrato la messa quando il corpo di Gesú Cristo era ancora crocefisso? – E in quello stesso tempo, Cristo si sarebbe potuto ancora definire uomo? – Dopo la resurrezione dei morti sarà permesso bere e mangiare, per prevenire la fame e la sete, come ora?
Inoltre vi sono innumerevoli sottigliezze ancora assai piú squisite: intorno agli istanti, alle nozioni, alle relazioni, alle formalità, alle essenze, alle ecceità [nella filosofia di Duns Scoto, 1266 ca-1308, ciò che determina l’ente] – che nessuno è capace di riconoscere, a meno di non avere occhi cosí acuti da poter scorgere nel buio oggetti inesistenti. Aggiungi poi le loro «sentenze», tanto assurde che a paragone i paradossi stoici appaiono volgarissime banalità. Affermano, ad esempio, che è un delitto minore sgozzare mille uomini, che rattoppare una volta tanto di domenica un paio di scarpe ad un povero, oppure che si deve lasciare che tutto il mondo perisca e sprofondi nel nulla, anziché dire una sola piccola insignificante bugia. [...]
LXI - Religiosi ipocriti e ignoranti
Felici quasi quanto costoro sono quelli che comunemente si chiamano religiosi o monaci con una denominazione quanto mai falsa, perché buona parte di essi è ben lontana dalla religione, ed in secondo luogo non c’è gente che s’incontri dappertutto e piú di frequente. Costoro, se non ci fossi io a soccorrerli, sarebbero senza dubbio i piú infelici di tutti. La folla li ha in odio a tal punto che incontrarli anche soltanto per caso è già considerato un segno di sfortuna; tuttavia essi s’illudono con magnifiche lusinghe. Anzitutto ritengono condizione essenziale per una vita pia essere tanto ignoranti da non saper neppure leggere. Inoltre, quando cantano i loro salmi numerati ma non capiti, con i loro ragli asinini credono di accarezzare le orecchie dei santi. Ve ne sono alcuni che dalla povertà e dalla mendicità traggono persino un guadagno rilevante, chiedono alle porte con alti lai un tozzo di pane, e, con gran danno dei mendicanti di professione, non c’è albergo, veicolo o battello a cui non si affaccino importuni. E cosí quei «soavissimi uomini», con la sporcizia, l’ignoranza, la rozzezza, l’impudenza, vogliono – a udir loro – darci un’immagine degli Apostoli.
Ma lo spettacolo piú ridicolo è vederli seguire in ogni loro atto norme rigidissime come se si regolassero su formule matematiche, trasgredire le quali potrebbe essere pericoloso. I sandali devono avere un certo numero di nodi, la cinghia un colore stabilito, la veste quei determinati pezzi, e la cintura dev’essere di una data stoffa e larghezza, il cappuccio di quella certa ampiezza e di quel certo colore, la tonsura larga tanto e non piú, ed hanno persino un orario per il sonno.
Chi non vede che questa uniformità, fra tanta diversità di corpi e di animi non può essere equa e costante? Ma pure con queste inezie non soltanto essi tengono in poco conto i comuni mortali, ma si ricoprono anche a vicenda del piú feroce disprezzo, e, mentre fanno voto di apostolica carità, non esitano però a fare tragedie per un modo diverso d’annodare la cintura o per un colore un poco piú scuro. Ve ne sono alcuni tanto pii e religiosi da non indossare che vesti di rozza lana (ma sottovesti di lino di Mileto), altri all’opposto portano abiti di lino e sottovesti di lana. Altri hanno in orrore il denaro come fosse un veleno, ma non evitano né le donne né il vino.
Sorprendente è il loro impegno nel distinguersi gli uni dagli altri nel modo di vita: tuttavia non aspirano a somigliare a Cristo, ma semplicemente a non somigliarsi tra di loro.
Gran parte della loro felicità consiste perciò nei nomi che usano dare ai loro ordini. Alcuni si chiamano Cordiglieri, e si dividono nei sottordini di Colettini, Minori, Minimi e Bollisti. Altri invece si chiamano Benedettini, altri ancora Bernardini, Brigidensi o Agostiniani. Inoltre vi sono i Guglielmiti e i Giacobiti, come se a tutti quanti non bastasse potersi chiamare Cristiani. [...]
LXIV - I prelati
Anche i papi, i cardinali, i vescovi, già da molto tempo si dedicano ad imitare con tutta serietà la vita dei regnanti, e quasi hanno ormai superato i loro modelli.
Se ciascuno di essi pensasse un poco di piú al significato della sua veste di candido lino, simbolo di vita incorrotta; della sua mitra dalle due punte trattenute da un solo nodo, simbolo della profonda conoscenza del Vecchio e del Nuovo Testamento; dei guanti che gli ricoprono le mani, a ricordargli che i sacramenti si somministrano con mani pure da ogni contaminazione umana; del pastorale, simbolo della insonne cura del proprio gregge, ed infine della Croce, segno di vittoria su ogni passione umana – se, ripeto, un vescovo pensasse a queste e a molte altre cose simili, non condurrebbe una vita grama e tormentata?
Viceversa, oggi fanno bene se badano a se stessi. Per il resto affidano la cura delle loro pecorelle a Cristo, o ne incaricano i loro «fratelli» o vicari. Non ricordano neppure piú il significato del loro nome di vescovo, che sta ad indicare lavoro, cure, attenzione. Si comportano da vescovi soltanto nell’arraffare denaro; allora non mancano certo di vigilanza né di attenzione. [...]
E passiamo ora ai Sommi Pontefici, vicari in terra di Cristo. Ma se veramente si sforzassero d’emulare la vita di Gesú, cioè, la povertà, le fatiche, la dottrina, la croce, il disprezzo della vita mondana; se ricordassero anche soltanto il significato del nome di Papa, cioè, padre, e del titolo di «Santità», chi su questa terra sarebbe piú infelice di loro? Chi sarebbe pronto a conquistarsi quel seggio con tutte le sue ricchezze? E, conquistandolo, a difenderlo con le armi, col veleno, insomma con qualsiasi mezzo?
Se mai sopraggiungesse la saggezza, di quanti vantaggi non li priverebbe? Ma che dico, la saggezza? Basterebbe soltanto un granello di quel sale di cui fa menzione Cristo! Quante ricchezze, quanti onori, quante giurisdizioni, vittorie, cariche, dispense, quanti tributi, indulgenze, cavalli, muli, cortigiani, divertimenti sfumerebbero. Vedete voi stessi qual fiera, qual messe, qual mare di bene ho riassunto in poche parole. E al loro posto subentrerebbero lunghe veglie, digiuni, lacrime, preghiere, orazioni, prediche, studi, sospiri e mille altre tormentose fatiche. Né bisogna dimenticare che resterebbero a questo modo sul lastrico tutti i copisti, scrivani, notai, legulei, promotori, segretari, palafrenieri, stallieri, usurai, lenoni (stavo quasi per aggiungere qualcosa di piú leggero, ma temo che non suoni troppo duro alle orecchie), insomma tutta la massa d’uomini che onera la Santa Sede – scusate, volevo dire che la onora. Sarebbe un delitto veramente inumano ed esecrando, sempre meno detestabile però di quello di voler ricondurre alla bisaccia e al bastone i principi stessi della chiesa, lumi del mondo. Ora invece, se c’è qualche cosa da fare, si affidano a Pietro e a Paolo, a cui, pensano, il tempo non manca, mentre riservano a se stessi onori e piaceri.
A questo modo, per opera mia in verità, nessuna categoria di mortali vive una vita piú molle e spensierata di quella dei papi, i quali credono di aver largamente adempiuto i loro doveri verso Cristo se con mistico e quasi scenico apparato, e con cerimonie religiose, e con sperpero di titoli quali: «Magnificenza», «Reverenza», «Santità», con maledizioni e benedizioni sostengono la loro parte di vescovi.
Far miracoli è considerato antiquato, stantio e per nulla adatto ai tempi nuovi; istruire il popolo, troppo faticoso; interpretare le Sacre Scritture, un esercizio da pedanti; pregare, una perdita di tempo; piangere, cosa meschina e degna di donnicciole; essere poveri, cosa spregevole; lasciarsi vincere, cosa vergognosa e poco degna di chi a malapena consente ai potenti della terra di baciargli i piedi. Morire, infine, è ritenuto cosa sgradevole, e farsi mettere in croce, addirittura infamante.
Articoli correlati
- Olanda (1466) - Svizzera (1536)
Erasmo da Rotterdam
Erasmo è noto per il suo pensiero di pace e riforma morale. Criticava aspramente la violenza e la guerra, e nelle sue opere denunciava le atrocità dei conflitti, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie e la tolleranza religiosa.9 novembre 2024 - Alessandro Marescotti - Breve scheda
Erasmo da Rotterdam (1467-1536)
Fu un intellettuale umanista che seppe ispirarsi ai principi di pace e tolleranza5 aprile 2020 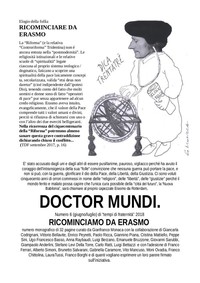 APPELLO
APPELLOElogio della follia - Ricominciare da Erasmo
Sottoscritto da personalità note del mondo della cultura da Moni Ovadia a Luigi Bettazzi, da Vito Mancuso a Gabriella Caramore12 febbraio 2018 - Laura Tussi
Sociale.network